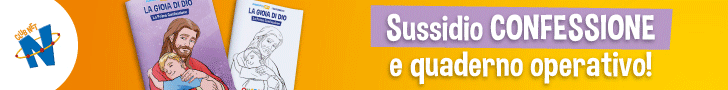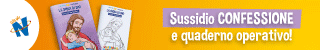TESTO Chi non da' Dio da troppo poco
padre Gian Franco Scarpitta ![]() Chiesa Madonna della Salute Massa Lubrense
Chiesa Madonna della Salute Massa Lubrense
XVI Domenica del Tempo Ordinario (Anno C) (20/07/2025)
Vangelo: Lc 10,38-42 ![]()

In quel tempo, 38mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo ospitò. 39Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. 40Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non t’importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». 41Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, 42ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta».
Benedetto XVI diceva che “Chi non da' Dio da' troppo poco”, anche quando dovesse dare tutte le sue sostanze in elemosina. Un'espressione che fa' riflesso all'Inno alla Carità di San Paolo (1Cor 13) dove si tratteggiano tutte le prerogative dell'amore vero, quello qualitativo ed espressivo della pazienza, della mitezza, mansuetudine, umiltà e modestia che Dio ci ha manifestato nel suo Figlio Gesù Cristo. Amore fatto cioè di lealtà e trasparenza, non di esibizionismo o millanteria; di vero disinteresse per l'altro, non di profitto intenzionale. Si può infatti dare in elemosina per ostentazione di sé, per una manovra di propaganda atta a propiziarci i favori degli altri, per motivi di interesse e si profitto o semplicemente per millanteria e vanità. Come pure per filantropia o per “motivi umanitari”, concetti già molto più lodevoli e motivati dei precedenti, ravvisanti presunzione e falso orgoglio. L'amore cristiano è invece “misericordia”, che vuol dire “aver pietà di cuore”, concetto già dissimile dall'”elemosina” che nell'accezione greco (eleo) indica semplicemente “provare compassione” o “aver pietà”. Nell'elemosina è possibile provare un sentimento passeggero di pietà o di compassione che suscita una lieve tenerezza per l'altro; nella misericordia si ha invece compassione in quanto si patisce con l'altro, entrando in empatia e in comunione piena con lui, facendo nostre le sue sofferenze e i suoi patimenti. Comporta avere “cuore”, cioè avvertire come proprie le necessità dell'altro, configurarsi all'altro con attenzione e partecipazione sull'esempio di chi ha avuto “cuore” per noi: Dio nel suo Figlio Gesù Cristo.
Carità e misericordia sono state rivolte a noi da Dio e nell'esserne diventati destinatari comprendiamo che nel prossimo, specialmente quello bisognoso e abbandonato, troviamo lo stesso Signore che ci viene incontro. Accogliere l'altro è accogliere Dio, ecco perché occorre la misericordia, molto più dell'elemosina.
La Lettera agli Ebrei esorta ad esercitare l'accoglienza con una sola spiegazione di fondo:
"Non dimenticate l'ospitalità; alcuni, praticandola, hanno accolto degli angeli senza saperlo." (Eb 13, 2). Il riferimento è all'episodio di cui alla Prima Lettura di oggi, che vede Abramo accogliere tre ignoti forestieri alle Quarce di Mamre. Essi si presentano nell'ora più calda del giorno (potremmo dire alle 15 di un pomeriggio d'estate) e Abramo, con la sola consapevolezza di dover accudire delle persone bisognose di rifocillarsi e di trovare sollievo, provvede a tutto ciò che occorre al loro ristoro. Esercita la carità e l'accoglienza disinteressatamente e senza riserve, animato solamente da quella fede e da quella disponibilità che lo aveva spinto sin dall'inizio a partire dalla sua patria affidandosi al solo Signore. L'accoglienza, così come la carità in genere, è espressione di una fede matura e comprovata; chi mostra generosità dimostra di credere e di questo ci rende edotti il "padre della fede " per eccellenza, Abramo Adesso infatti questi è convinto di incontrare lo stesso Signore nel prossimo forestiero e pellegrino e coloro che gli si manifestano alla fine si rivelano essere proprio Dio e i suoi angeli. Alcuni intravvedono in questi tre soggetti forestieri le Tre Persone della Trinità che a loro si presentano sotto false sembianze. Abramo e Sara otterranno un figlio nonostante la loro tarda età per la fede che Abramo ha tramutato in carità operosa.
L'episodio rintuzza il concetto qualitativo dell'amore, la realtà vera del donarsi che esclude millanterie e personali autoesaltazioni, ma che vuole semplicemente gratuità e spontaneità. E soprattutto amore che scaturisce dalla fede e dalla speranza e dalla capacità di saper prescindere da noi stessi e guardare oltre con occhi di fiducia che ci dischiudano nuovi orizzonti, perché siamo capaci di vedere Dio attorno a noi, di contemplarlo in ogni cosa e soprattutto di amarlo nei fratelli per mezzo dei quali Egli ci si manifesta. Per questo la contemplazione è inane e infruttuosa quando non vi faccia seguito l'operatività concreta (contemplata aliis tradere), ma allo stesso tempo anche l'azione è amorfa e vacua quando non sia accompagnata dalla contemplazione, dalla preghiera e dalla Parola che ne alimentano il senso e il valore.
Ne è esplicazione l'episodio in cui Gesù viene invitato da due sorelle, Marta e Maria, dagli atteggiamenti differenti e tuttavia complementari: l'una iperattiva, solerte e zelante nell'operosità concreta; l'altra meditativa che ama solamente ascoltare quanto Gesù le sta dicendo. Gesù esalta la scelta di ascolto e di attenzione da parte di Maria, perché quella è “la parte migliore”, che rappresenta il senso della vita in Cristo, la volontà di restare se stessi nonostante i continui affaccendamenti, gli impegni e gli assorbimenti del quotidiano. E solo nel confronto con la Parola l'uomo trova se stesso e non si perde. Marta rappresenta forse l'attivismo, la preoccupazione in eccesso che dovrebbe limitarsi semplicemente ad essere occupazione (non preoccupazione). Azione e contemplazione vanno sempre coniugate e rese simbiotiche, l'una accanto all'altra, come del resto anche la teoria e la prassi. Contemplare e agire con il dovuto equilibrio, scongiurando che l'uomo o l'altro debordino in eccessi impropri, rende qualitativa, sensata, consolidata ogni attività e ogni opera, realizzando che in ogni cosa si comunichi sempre Dio. In modo che nel dare non si dia troppo poco.