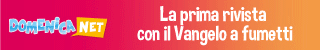TESTO Dal trono eucaristico a quello dei crocifissi di oggi: la stessa comunione
XXXIV Domenica del Tempo Ordinario (Anno A) - Cristo Re (22/11/2020)
Vangelo: Mt 25,31-46 ![]()

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «31Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. 32Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, 33e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. 34Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, 35perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, 36nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”. 37Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? 38Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? 39Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. 40E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. 41Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, 42perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, 43ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato”. 44Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?”. 45Allora egli risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l’avete fatto a me”. 46E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna».
Il racconto del giudizio finale è un genere letterario che non corrisponde a quello delle parabole.
È una scena di giudizio universale con linguaggio apocalittico il cui contenuto si riscontra anche nella letteratura rabbinica, egiziana e in quella apocalittica, in particolare nel libro di Enoch, diffuso e commentato ai tempi di Gesù. Interpretato alla lettera provoca una sensazione di paura. Il giudizio è un esame. Ci si troverà di fronte ad un re: è il «Figlio dell'uomo, seduto sul trono della sua gloria» Mt 25, 31), è Gesù Cristo risuscitato, il nostro re, di cui oggi si celebra la solennità liturgica. Questo re è paragonato ad un pastore.
L'unico linguaggio parabolico del racconto è il paragone con il pastore che «separa le pecore dalle capre» (Mt 25,32). È un chiaro riferimento alla profezia di Ezechiele che abbiamo ascoltato nella prima lettura: Dio stesso si prenderà cura del suo popolo come un buon pastore perché i pastori terreni, i re di Giuda e di Israele, non sono stati fedeli alla loro missione! Ritornando al racconto del giudizio si rimane impressionati dalla divisione delle due categorie di persone, paragonate alle pecore e alle capre, cioè i «benedetti» del Padre del re (Mt 25,34) e i «maledetti» destinati al «fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli» (Mt 25,41). Questo linguaggio apocalittico di ricompensa e di condanna contrasta con la bellissima descrizione del pastore fatta dal profeta Ezechiele. Anche lì la scena è di giudizio, ma prevale la tenerezza e la preoccupazione di recuperare la pecora smarrita: «Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare. Oracolo del Signore Dio. Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all'ovile quella smarrita, fascerò quella ferita e curerò quella malata, avrò cura della grassa e della forte; le pascerò con giustizia. A te, mio gregge, così dice il Signore Dio: Ecco, io giudicherò fra pecora e pecora, fra montoni e capri» (Ez 34, 15-16).
Per ben quattro volte vengono ripetute le sei azioni di misericordia verso l'affamato, l'assetato, il nudo, il forestiero, l'ammalato e il carcerato. Due volte sono messe in bocca al re giudice, due volte rispettivamente ai benedetti e ai maledetti, i quali si stupiscono di un particolare inedito nella letteratura rabbinica ed extrabiblica: tutti, appartenenti ai due gruppi distinti, non erano consapevoli che lo stesso re che stava mettendo in pratica il giudizio si identificasse con l'affamato, l'assetato, il nudo, il forestiero, l'ammalato e il carcerato: «Quando ti abbiamo visto e ti abbiamo...? [...] Quando ti abbiamo visto e non ti abbiamo...?» (Mt 25,37-39.44) Quell' «Io» identificato con i poveri sofferenti e addirittura con i carcerati incalliti peccatori insieme a quell' «l'avete fatto a me - non l'avete fatto a me» fa da unico criterio per definire chi sta dalla parte dei benedetti e chi sta dalla parte dei maledetti.
Suscita perplessità la durezza del giudizio, perché sembra che non vi siano sfumature: i benedetti appaiono come gente che ha sempre usato misericordia con le sei categorie di persone necessitate, i maledetti sembrano gente senza scrupoli, senza un minimo di misericordia nei confronti degli altri. Se ciascuno di noi valuta seriamente le sue azioni di cui si sente responsabile si rende conto di non essere né completamente giusto e nemmeno completamente malvagio. Infatti ci si ricorda di essere stati misericordiosi in certe occasioni e di essere stati indifferenti e poco attenti in altre occasioni, cioè ciascuno di noi oscilla dal sentirsi dalla parte delle pecore e dalla parte delle capre, dalla parte dei benedetti e dalla parte dei maledetti. Possiamo essere promotori di comunione o di divisione, di ospitalità o di chiusura egoistica, di solidarietà o di conflitto, di rispetto e di abuso verso l'altro. Se è vero che la nostra identità personale è in continuo divenire perché dipende dalla qualità delle relazioni che consapevolmente riusciamo ad intessere con l'altro, l'essere identificati tra le pecore o tra le capre alla fine della vita è un avvertimento a vigilare sul nostro modo di tessere relazioni nel qui ed ora del nostro presente. Il giudizio finale della nostra vita sta già avvenendo giorno dopo giorno quando impariamo a usare responsabilmente la nostra coscienza e la nostra libertà di azione. Come essere responsabilmente liberi e consapevoli della qualità delle nostre relazioni?
Per noi cristiani c'è un riferimento essenziale: Gesù Cristo.
Bisogna chiarire su quale trono il Figlio dell'uomo sia seduto.
Il racconto ci proietta nel futuro, quando invece il trono del Figlio dell'uomo noi cristiani lo conosciamo già da duemila anni: è il patibolo della sua croce.
Subito dopo il racconto del giudizio finale l'evangelista Matteo mette in bocca a Gesù le seguenti parole: «Voi sapete che fra due giorni è Pasqua e che il Figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso» (Mt 26, 2)
Quindi il giudizio finale è già in atto nel qui ed ora della nostra esistenza, perché noi già sappiamo che il Cristo risuscitato ha trasformato lo scandalo e la stoltezza della croce in trono di gloria.
Il trono della gloria del nostro Signore Gesù Cristo è il suo corpo e il suo sangue memoriale della sua morte e morte di croce e della sua risurrezione in attesa della sua venuta finale.
San Paolo lo ricorda ai Corinti, mettendoli in guardia sulla loro superficialità di entrare in comunione con il dono eucaristico, quando poi, nella stessa comunità cristiana si verificavano discriminazioni e mancanze di rispetto verso i più poveri: «Ciascuno esamini se stesso e poi mangi di questo pane e beva di questo calice, perché chi mangia e beve e beve senza riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna» (1Cor 11, 28).
Il corpo e sangue del Signore che mangiamo e beviamo durante nella celebrazione eucaristica lo si adora e lo si rispetta autenticamente nella maniera con cui noi ospitiamo nella nostra comunità cristiana e nella nostra vita quotidiana i poveri, gli ultimi, i più sofferenti.
Le sue parole di Signore del cielo e della terra, di risuscitato, ci sono già arrivate al nostro udito, non abbiamo più scuse per dire la stessa domanda appena ascoltata: «Quando ti abbiamo visto e ti abbiamo...? [...] Quando ti abbiamo visto e non ti abbiamo...?»
La scena del giudizio finale è qui ed ora fino all'ultimo nostro respiro alla soglia della nostra morte.
Consiste in un invito ad avere uno sguardo ospitale verso gli altri, soprattutto con i sofferenti, con i poveri, con gli esclusi, con i peccatori, con i nemici, con coloro che maggiormente scomodano il nostro cuore facilmente attaccato a tante sicurezze che possono diventare i nostri idoli: il denaro, i titoli accademici, il proprio lavoro di successo, le cose materiali che ci siamo acquistati e conquistati con fatica.
Per la morte e risurrezione di Gesù Cristo, già avvenuta una volta per tutte, ciascuno di noi è un peccatore già perdonato, già riscattato nella sua dignità di figlio amato del Padre mediante il dono gratuito dello Spirito Santo effuso nel cuore.
La prima eucaristia, celebrata da Gesù stesso nell'ultima cena, fu un dono gratuito di se stesso anche a Giuda il traditore, anche a Pietro il rinnegatore. L'eccedenza di dono che viviamo di fronte al “trono” eucaristico del corpo e sangue di Cristo che si dona a noi nella celebrazione della santa messa ci invita a completare la stessa comunione con il suo corpo e con il suo sangue ospitando con rispetto profondo l'affamato, l'assetato, l'impoverito della sua dignità umana, il migrante, l'ammalato, l'uomo affranto dal peso delle sue azioni peccaminose che sta scontando la sua pena in un carcere, gli esseri umani seduti sui troni esistenziali della storia di oggi che sono le croci della miseria, delle guerre, dei letti di ospedale, delle case di riposo diventate prigioni a causa del covid, delle baraccopoli del mondo, dei barconi della disperazione, delle stanze della solitudine. Il trono di gloria che vediamo concretamente in un'ora di adorazione eucaristica in chiesa diventa il trono ripugnante delle tantissime croci dei crocifissi della storia di ogni giorno, che incontriamo fuori della chiesa, sui quali siede il Cristo Signore, presente in loro, per invitarci tutti ad adorarlo non solo con canti e preghiere che rinnovano il nostro “sentirci amati”, ma anche con azioni concrete di solidarietà, di prossimità, di condivisione, di comunione con i poveri, che rinnovano la nostra vocazione e missione di “amare”. Dov'è questo Regno del Padre di cui Cristo è Signore oggi? È nella relazione di comunione con i sofferenti perché di essi è il Regno del Padre nel qui ed ora della storia dell'umanità, fino al giorno della venuta definitiva del Cristo alla fine dei tempi.